Si fa presto a dire "Infografica"
Per cercare di chiarire cosa sia una infografica possiamo tracciare una storia dell'infografica attraverso l'esame di alcuni esempi tratti dalla storia della nostra cultura, fino ad arrivare, in un successivo post fino ai nostri giorni per poter prendere in considerazione le infografiche interattive e dinamiche che la comunicazione digitale consente di realizzare
Cominciamo con un disegno che rappresenta l'universo aristotelico - telomeico realizzato da Piero Apiano, cartografo, matematico e astronomo tedesco vissuto a cavallo tra il XV e XVI secolo. Questa illustrazione rappresenta in modo compiuto e completo la concezione del cosmo che ha dominato la cultura occidentale per circa 2.500 anni. Siamo di fronte ad uno dei paradigmi più potenti e duraturi, una matrice di senso che ha consentito per decine di secoli di "inquadrare" qualsiasi cosa accedesse nell'universo.
Tutto ciò che esiste trova una collocazione generale in questo "disegno": la terra, i pianeti, il dualismo tra mondo sublunare e celeste, dio e gli uomini, le costellazioni e i segni dello zodiaco, i moti degli astri, i 4 elementi e l'etere, la fisica terrestre e celeste. Non si tratta, ovviamente, di dati statistici e specifici, ma del contesto generale in cui tali dati vanno inseriti per divenire informazioni. L'infografica di Apiano sintetizza i dati, ovvero fornisce una rappresentazione visiva unitaria del molteplice (come direbbe Kant), fornendo uno schema di organizzazione a dati e nozioni di varia natura: fisica, astronomica, metafisica, teologica, astrologica.
Le Infografiche "strettamente parlando"
Una Conclusione finalmente!
La rappresentazione grafica delle informazioniè sempre stato uno degli aspetti principali dell'agire comunicativo, in un certo senso è all'origine della stessa nascita della scrittura, che altro non è se non rappresentazione grafica della lingua parlata.
Altro fondamentale aspetto che da sempre caratterizza la rappresentazione grafica delle informazioni è la ricerca di un ordine che trasformi i dati in informazioni imponendo ad essi una struttura relazionale. Anche per questo secondo aspetto siamo di fronte a uno degli aspetti principali dell'agire conoscitivo umano, la ricerca del senso, del logos che è alla base nascita della filosofia e delle scienze.
Anche l'odierno successo delle infografiche nasce dalla stessa ragione, la quantità di dati oggi in nostro possesso è tale da risultare ingovernabile, ma non si tratta solo del problema dell'overload informativo, si tratta della difficoltà di "inquadrare" i dati, ovvero inserirli in un contesto strutturato, categorizzato, che li renda comprensibili e esplorabili, senza la qual cosa i dati non saranno mai informazioni, ma caos, opposto del logos, disordine.
Infografica? Chi è costei?
Senza indulgere in peraltro interessanti questioni di natura storica, semiotica, epistemologica e semantica, assumiamo il termine infografica nel suo senso più ampio di "information design" ben espresso dalla parola "infographic"che nasce dalla fusione delle parole informazione (information) e grafica (graphic), ovvero: visualizzazione delle informazioni in cui prevale l'aspetto grafico e visivo su quello testuale. Componente essenziale dell'attuale sviluppo delle infografiche è la digitalizzazione e l'elaborazione computerizzata delle informazioni e della loro visualizzazione.
In questa accezione molto ingenua e generale molte cose possono essere etichettate come Infografiche: mappe concettuali e mentali, diagrammi di flusso, istogrammi, mappe, schemi, ecc.
Per cercare di chiarire cosa sia una infografica possiamo tracciare una storia dell'infografica attraverso l'esame di alcuni esempi tratti dalla storia della nostra cultura, fino ad arrivare, in un successivo post fino ai nostri giorni per poter prendere in considerazione le infografiche interattive e dinamiche che la comunicazione digitale consente di realizzare
I greci, come sempre! Apiano e il cosmo aristotelico - tolemaico
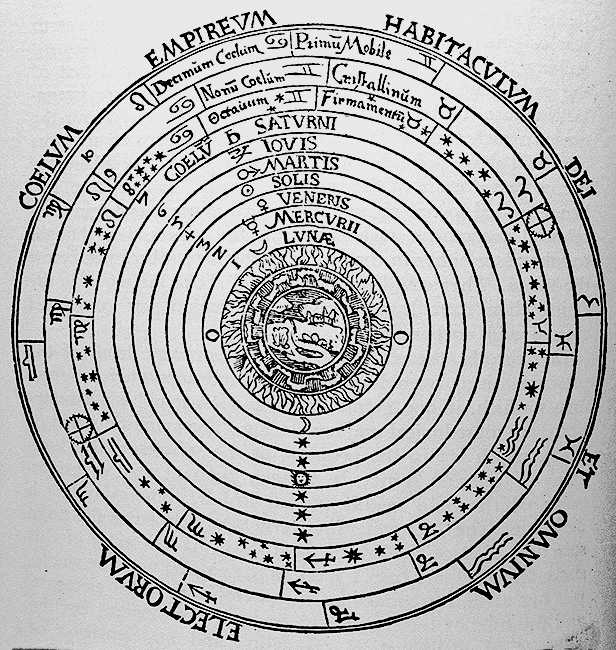 |
| Piero Apiano, XVI secolo, illustrazione dell'universo aristotelico - tolemaico |
Tutto ciò che esiste trova una collocazione generale in questo "disegno": la terra, i pianeti, il dualismo tra mondo sublunare e celeste, dio e gli uomini, le costellazioni e i segni dello zodiaco, i moti degli astri, i 4 elementi e l'etere, la fisica terrestre e celeste. Non si tratta, ovviamente, di dati statistici e specifici, ma del contesto generale in cui tali dati vanno inseriti per divenire informazioni. L'infografica di Apiano sintetizza i dati, ovvero fornisce una rappresentazione visiva unitaria del molteplice (come direbbe Kant), fornendo uno schema di organizzazione a dati e nozioni di varia natura: fisica, astronomica, metafisica, teologica, astrologica.
Quali le caratteristiche di questa illustrazione? Procedendo senza alcuna pretesa di sistematicità possiamo stilare il seguente elenco:
# traduce visivamente un quadro concettuale, di origini greche, consistente in un ordine cosmico paradigmatico
# applica tale quadro ai dati generali strutturandoli secondo relazioni grafiche rappresentate su una superficie bidimensionale
# le relazioni di ordine logico - concettuale trovano espressione nella disposizione spaziale reciproca dei vari elementi che formano l'immagine
# prevale decisamente l'elemento visuale, il design, su quello testuale. Le parole sono poche e in genere si preferisce usare simboli piuttosto che la scrittura alfabetica
# la mappa può essere navigata e/o esplorata in molti modi e secondo percorsi diversi, ma tutti entro un quadro condiviso e intersoggettivamente valido
# l'illustrazione non costituisce solo un tentativo riuscito di ordinare i dati, ma anche un meccanismo euristico che può fornire un supporto all'apprendimento o, addirittura, portare alla proposizione di nuove conoscenze
# combinatoria e dinamica
Una infografica raffigurante l'Enciclopedia Medioevale delle Scienze# combinatoria e dinamica
L'illustrazione di Apiano non costituisce un caso eccezionale ma rientra in quella che era una consuetudine risalente alla miniaturistica medioevale e che si riscontra, per esempio, nelle raffigurazione del sistema del sapere costituito dalle sette atti liberali, come emerge da questa "infografica" del XII secolo opera di Herrad von Landsberg,
Anche in questo caso siamo di fronte a una rappresentazione visiva che propone il sistema gerarchico di relazione tra le scienze che nel loro insieme costituiscono l'enciclopedia medioevale del sapere: il sistema delle 7 arti liberali, anche questo derivato dalla cultura greca classica.
Il disegno mostra i diversi comparti del sapere, i loro rapporti reciproci, il processo della produzione e circolazione dei flussi conoscitivi, nell'ottica propria della cultura medioevale. Alle caratteristiche rilevate in precedenza possiamo aggiungere
# la presenza del colore che aggiunge un ulteriore livello di significato e raffigurazione simbolica
# l'utilizzo di elementi architettonici con funzione comunicativa
# l'accuratezza del disegno che comporta la rappresentazione e comunicazione di ulteriori informazioni, quali gli strumenti impugnati dai personaggi raffiguranti le varie arti, che ricordano le icone delle infografiche moderne
# anche in questo caso manca la dimensione quantitativa
Il disegno mostra i diversi comparti del sapere, i loro rapporti reciproci, il processo della produzione e circolazione dei flussi conoscitivi, nell'ottica propria della cultura medioevale. Alle caratteristiche rilevate in precedenza possiamo aggiungere
# la presenza del colore che aggiunge un ulteriore livello di significato e raffigurazione simbolica
# l'utilizzo di elementi architettonici con funzione comunicativa
# l'accuratezza del disegno che comporta la rappresentazione e comunicazione di ulteriori informazioni, quali gli strumenti impugnati dai personaggi raffiguranti le varie arti, che ricordano le icone delle infografiche moderne
# anche in questo caso manca la dimensione quantitativa
 |
| Le 7 arti liberali, Hortus Deliciarum, Herrad von Landsberg, XII sec. |
Leibniz e l'Ars Combinatoria: la nascita dell'ideale Computazionale in una "Infografica"
L'ideale combinatorio di Leibniz, da lui definita Charateristica Universalis, consiste nella costruzione di un sistema di calcolo attraverso cui si potesse derivare la totalità del sapere a partire da alcune premesse e regole di inferenza originarie, segna la nascita del sogno computazionale, che trova piena fioritura ai nostri giorni, ma più come un incubo che come un sogno. Infatti il sogno di Leibnizè quello di individuare un algoritmo che riduca la dimostrazione a calcolo, ovvero ad una procedura automatica di tipo inferenziale e che sia tale da poter essere implementata su un meccanismo.
Se questo aspetto del sogno leibniziano si è avverato, non altrettanto è accaduto con l'altra componente fondamentale dell'ideale del calcolemus: la riduzione della totalità dei dati a un sistema unico, coerente e completo. Trascurando gli aspetti logici di questo problema, insiti nei teoremi limitativi, basta considerare l'attuale problema dell'Information Overload e dei Big Data che nascono dalla combinazione di due criticità:
# l'enorme dimensione quantitativa che i dati disponibili hanno raggiunto e
# la difficoltà di combinarli entro un sistema unico e universale che conferisca loro un senso assoluto e stabile.
 |
| I 4 elementi aristotelici secondo Leibniz, Dissertatio de arte combinatoria, 1666 |
L'infografica di Leibniz si basa su due teorie fondamentale della scienza aristotelica, la fisica e la logica. Secondo la dottrina degli elementi della fisica aristotelica, i 4 elementi sono posti ai vertici di un quadrato inscritto in una circonferenza, ai vertici di in un altro quadrato concentrico sono inserite le loro qualità prime: caldo, umido, freddo, secco. L'organizzazione di questi elementi coincide con quelle del quadrato degli opposti della logica aristotelica secondo cui si possono calcolare tutte le possibili combinazioni dei vari tipi di proposizioni determinandone a priori la verità. Abbiamo raffigurate in questa illustrazione tutte le trasformazioni possibili degli elementi in base ad aggiunte e sottrazioni delle loro qualità.
Trascurando la questione fisica e filosofica, possiamo riscontrare anche in questa "infografica" le stesse caratteristiche viste in precedenza e trarre una prima fondamentale conclusione: rispetto alle infografiche attualmente in uso la principale differenza non è comunicativa, non riguarda il design, la logica di composizione della figura, ma consiste nel fatto che manca totalmente qualsiasi riferimento numerico, mentre l'odierna diffusione delle infografiche è strettamente connessa al trattamento dei numeri. I dati che le infografiche digitali raffigurano sono prevalentemente numerici e fanno riferimento a rilevazioni e misurazioni di fenomeni specifici, l'uso della raffigurazione delle informazioni in età antica e moderna è invece prevalentemente riferito a concetti generali secondo un approccio più aprioristico e deduttivo, sarà solo con la scienza e la quantificazione e matematizzazione dell'esperienza che si aprirà la strada per il trattamento matematico dei dati.
Le Infografiche "strettamente parlando"
Nel 1626 viene pubblicato il trattato di astronomia Rosa Ursina sive Sol di Christoph Scheiner, astronomo e fisico gesuita tedesco, per illustrare i modelli seguiti dalla rotazione del sole vengono utilizzate illustrazioni che possono essere definite infografiche in senso proprio
 |
| C. Scheiner, Rosa Ursina sive Sol, pp. 339. immagine 64 |
Dalla voce di Wikipedia English dedicata alle infografiche, si apprende che nel 1857 Florence Nightingale realizzò un'infografica che illustrava le cause della mortalità dei soldati durante la guerra di Crimea, per convincere la regina Vittoria a migliorare le condizioni degli ospedali militar. L'infografica utilizza una combinazione di grafici a barre e a torta, ottenendo un "Coxcomb Chart", un grafico a "Cresta di gallo"
 |
| Diagram by Florence Nightingale, causes of mortality during Crimean War |
Per proseguire questa carrellata di infografiche delle origini, un diagramma del 1840 che sembra realizzato oggi, tratto da un articolo di Luke Hinchliffe pubblicato il 27/01/2015 su Kurtosys: Storytelling with Data Visualization. Viene rappresentata la diffusione del colera a Londra in relazione alla temperatura.
 |
| 1840: Temperaturta e diffusione del colera a Londra |
Possiamo concludere con un'altra infografica segnalata nello stesso articolo e risalente al 1917, si tratta di un poster della prima guerra mondiale dedicato al pane e in cui il disegno, persino i colori e la grafica, fanno pensare a una delle attuali infografiche.
 |
| 1917, Bread, first in war, first in peace |
Una Conclusione finalmente!
Da quanto visto fin qui emerge chiaramente che tutti gli elementi che caratterizzano ciò che oggi chiamiamo infografica sono il risultato di un lungo percorso storico che alcuni vogliono far risalire addirittura alle pitture rupestri della grotta di Altamira. Anche senza spingerci così indietro nel tempo, abbiamo documentato come la nascita e crescita dell'infografica, fino al raggiungimento dell'età adulta, sia da collocarsi tra il tardo medioevo e il XIX secolo. In tale arco di tempo infatti, tutti gli elementi costitutivi di questo media giungono a maturazione.
Semplificando possiamo dire che le componenti fondamentali di un'infografica sono: forma visuale, contenuto, conoscenza
Per quanto riguarda gli elementi grafico - visuali: icone, simboli, disegni, elementi geometrici, forme grafiche, ecc. sono presenti in modo massiccio sin dal medioevo. Anche la disposizione di questi elementi nello spazio acquista un significato informativo e comunica conoscenza, tutto nella grafica è da subito finalizzato alla espressione del contenuto, a dare una forma al contenuto. Anche i colori, diventano parte di quella struttura grafica complessiva e coerente che produce significato e rende leggibile l'infografica "antica". Altro aspetto interessante che possiamo individuare fin dalle prime illustrazioni che abbiamo presentato, è che la grafica delinea dei percorsi che vengono suggeriti all'osservatore. Si tratta di immagini statiche, che vanno però esplorate seguendo le "indicazioni" grafiche e cromatiche, ci si "deve"muovere all'interno dell'immagine "interagendo", seppur solo visivamente e intellettualmente, con essa, ma la strada che porterà a una forma di interazione concreta, grazie alla digitalizzazione, è già potenzialmente presente.
Anche l'elemento conoscitivoè da subito in primo piano in un duplice senso. In primo luogo tali immagini corrispondono sul piano alle categorie concettuali, loro scopo è quello di "trasformare" i dati in "informazioni" dotate di senso, in quanto collocate entro un contesto teorico che ne determina il significato. Quindi l'infografica è generata a partire dal complesso di teorie, conoscenze, premesse filosofico - culturali che fungono da elementi strutturanti dei dati, tale quadro concettuale di fondo viene reso con espedienti grafico - visuali e che determinano "come" i dati sono raffigurati e quindi semantizzati. In questo primo senso l'infografica assume, da subito, un valore comunicativo e pedagogico, suo scopo è favorire nell'osservatore l'apprendimento, in questo caso non tanto e non solo del contenuto veicolato, ma dei quadri concettuali che lo strutturano. In secondo luogo l'infografica è a sua volta un meccanismo euristico generatore di senso. La possibilità di esplorarla e muoversi al suo interno attraverso percorsi e meccanismi combinatori, può portare a nuove ipotesi e nuove conoscenze.
I contenuti che l'infografica organizza e comunica sono il terzo elemento costitutivo di essa. Qui troviamo la principale differenza tra le "infografiche classiche" e quelle "moderne e contemporanee". Mentre in età classica e medioevale i contenuto sono conoscenze e concetti generali, presenti anche nelle infografiche contemporanee, a partire dalla rivoluzione scientifica si va affermando, fino a prevalere, la rappresentazione di dati numerici relativi a fenomeni specifici.
Nel caso di Christoph Scheiner si tratta dei dati relativi all'orbita solare, quindi dati numerici frutto della operazione di matematizzazione della natura. Questa tendenza viene a investire sempre di più anche lo studio della società, come mostrano le infografiche di Nightingale e quella relativa all'epidemia di colera a Londra.
Oggi la quantificazione e misurazione di ogni aspetto della vita sociale e dell'attività umana è il paradigma dominante della conoscenza: qualsiasi fenomeno di qualsiasi tipo viene "descritto" in termini quantitativi. Questo determina una estrema sovrabbondanza di dati, che a sua volta pone l'esigenza di interpretare e organizzare tali tali "dati" come decisiva. Da ciò la necessità di strumenti sempre più efficaci e potenti, come il trattamento algoritmico dei Big Data.
La strada dell'infografica è un'altra, più umanistica rispetto a quella dei Big Data e della Business Intelligence. Nelle infografiche infatti la comunicazione mira alla comprensione e interpretazione di un fenomeno secondo schemi intuitivi e immediati e attraverso una mediazione concettuale in cui segno e disegno offrono una traduzione dei concetti in imamgini.
Con la digitalizzazione si impone l'attuale infografica caratterizzata da interattività e dinamicità. Ma questa è un'altra storia.
Semplificando possiamo dire che le componenti fondamentali di un'infografica sono: forma visuale, contenuto, conoscenza
Per quanto riguarda gli elementi grafico - visuali: icone, simboli, disegni, elementi geometrici, forme grafiche, ecc. sono presenti in modo massiccio sin dal medioevo. Anche la disposizione di questi elementi nello spazio acquista un significato informativo e comunica conoscenza, tutto nella grafica è da subito finalizzato alla espressione del contenuto, a dare una forma al contenuto. Anche i colori, diventano parte di quella struttura grafica complessiva e coerente che produce significato e rende leggibile l'infografica "antica". Altro aspetto interessante che possiamo individuare fin dalle prime illustrazioni che abbiamo presentato, è che la grafica delinea dei percorsi che vengono suggeriti all'osservatore. Si tratta di immagini statiche, che vanno però esplorate seguendo le "indicazioni" grafiche e cromatiche, ci si "deve"muovere all'interno dell'immagine "interagendo", seppur solo visivamente e intellettualmente, con essa, ma la strada che porterà a una forma di interazione concreta, grazie alla digitalizzazione, è già potenzialmente presente.
Anche l'elemento conoscitivoè da subito in primo piano in un duplice senso. In primo luogo tali immagini corrispondono sul piano alle categorie concettuali, loro scopo è quello di "trasformare" i dati in "informazioni" dotate di senso, in quanto collocate entro un contesto teorico che ne determina il significato. Quindi l'infografica è generata a partire dal complesso di teorie, conoscenze, premesse filosofico - culturali che fungono da elementi strutturanti dei dati, tale quadro concettuale di fondo viene reso con espedienti grafico - visuali e che determinano "come" i dati sono raffigurati e quindi semantizzati. In questo primo senso l'infografica assume, da subito, un valore comunicativo e pedagogico, suo scopo è favorire nell'osservatore l'apprendimento, in questo caso non tanto e non solo del contenuto veicolato, ma dei quadri concettuali che lo strutturano. In secondo luogo l'infografica è a sua volta un meccanismo euristico generatore di senso. La possibilità di esplorarla e muoversi al suo interno attraverso percorsi e meccanismi combinatori, può portare a nuove ipotesi e nuove conoscenze.
I contenuti che l'infografica organizza e comunica sono il terzo elemento costitutivo di essa. Qui troviamo la principale differenza tra le "infografiche classiche" e quelle "moderne e contemporanee". Mentre in età classica e medioevale i contenuto sono conoscenze e concetti generali, presenti anche nelle infografiche contemporanee, a partire dalla rivoluzione scientifica si va affermando, fino a prevalere, la rappresentazione di dati numerici relativi a fenomeni specifici.
Nel caso di Christoph Scheiner si tratta dei dati relativi all'orbita solare, quindi dati numerici frutto della operazione di matematizzazione della natura. Questa tendenza viene a investire sempre di più anche lo studio della società, come mostrano le infografiche di Nightingale e quella relativa all'epidemia di colera a Londra.
Oggi la quantificazione e misurazione di ogni aspetto della vita sociale e dell'attività umana è il paradigma dominante della conoscenza: qualsiasi fenomeno di qualsiasi tipo viene "descritto" in termini quantitativi. Questo determina una estrema sovrabbondanza di dati, che a sua volta pone l'esigenza di interpretare e organizzare tali tali "dati" come decisiva. Da ciò la necessità di strumenti sempre più efficaci e potenti, come il trattamento algoritmico dei Big Data.
La strada dell'infografica è un'altra, più umanistica rispetto a quella dei Big Data e della Business Intelligence. Nelle infografiche infatti la comunicazione mira alla comprensione e interpretazione di un fenomeno secondo schemi intuitivi e immediati e attraverso una mediazione concettuale in cui segno e disegno offrono una traduzione dei concetti in imamgini.
Con la digitalizzazione si impone l'attuale infografica caratterizzata da interattività e dinamicità. Ma questa è un'altra storia.
Una Infografica sulla Storia delle Infografiche
Una interessante infografica sulla storia delle infografiche ralizzata in forma di timeline e che pone la nascita delle infografiche nel 40.000 a.C. ,con le prime pitture rupestri della grotta di Altamira in Spagna.
Una interessante infografica sulla storia delle infografiche ralizzata in forma di timeline e che pone la nascita delle infografiche nel 40.000 a.C. ,con le prime pitture rupestri della grotta di Altamira in Spagna.
